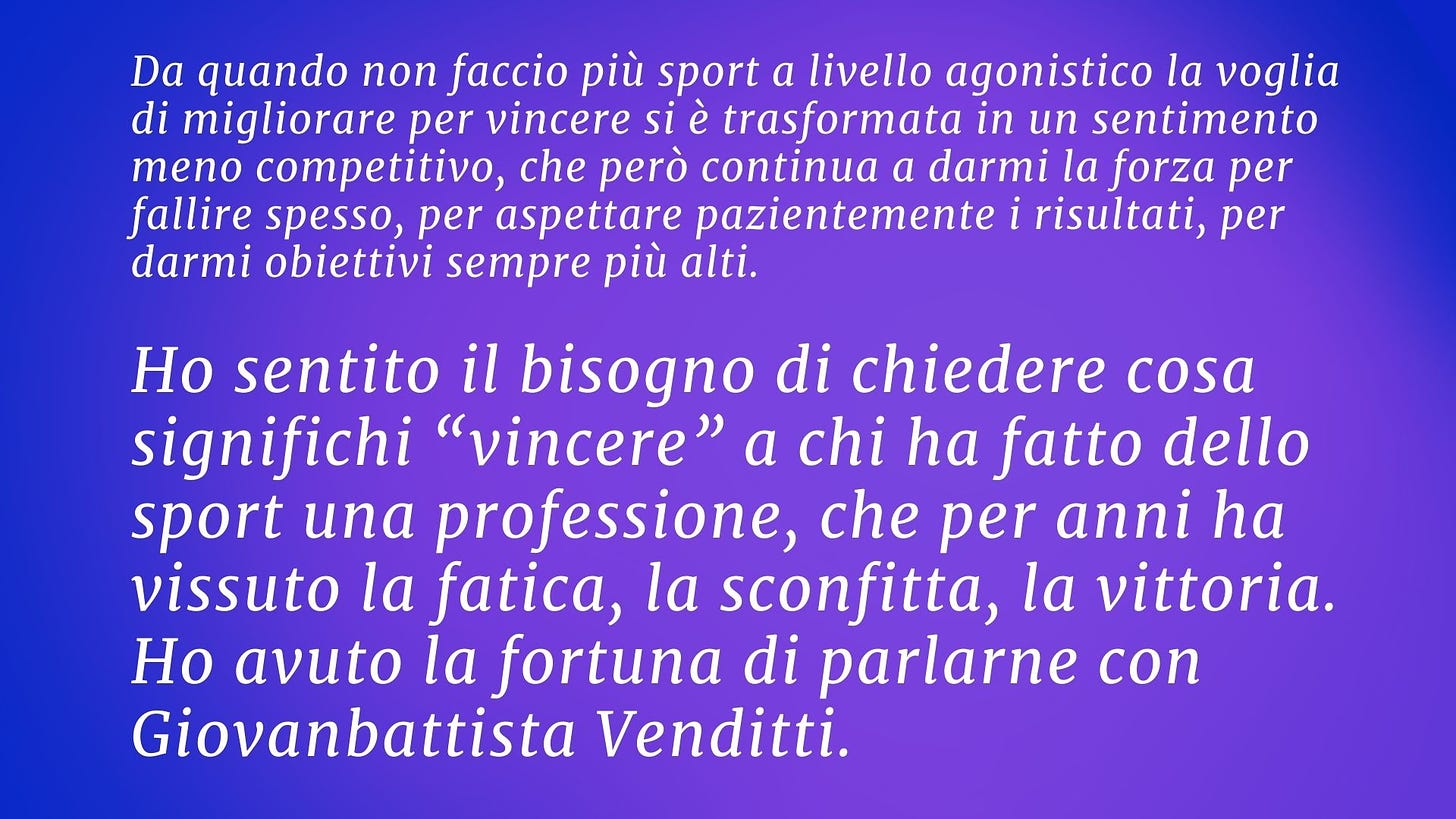Nell’estate dei miei 15 anni ho incontrato Robin,
e ho scoperto che mi diverto di più
quando non sono sicura di vincere.
Robin è un cavallo, e al tempo mi era stato presentato più o meno così: “Guarda quant’è bello, andrai con lui ai campionati italiani tra un mese. Auguri”. Era bello davvero, e anche completamente fuori di testa.
Fargli accettare che dovevamo allenarci insieme era diventata la mia sfida personale, e per accelerare il processo – che avrebbe portato con simile probabilità alla rottura di tutti i miei arti o alla vittoria della gara – mi sono autoinflitta un agosto faticoso, fisicamente e psicologicamente.
Le mie giornate erano tutte così: salivo in sella, Robin tentava di buttarmi giù, dopo un’ora di lotta si fermava e si faceva riportare in stalla. Tutti i giorni, due volte al giorno prima dei pasti.
Ogni mio tentativo sembrava inutile: io e Robin non ci capivamo.
Mancavano 10 giorni alla gara e io, come ogni giorno, sono salita in sella, stravolta. Volevo far funzionare la nostra coppia, con tutte le mie forze.
All’improvviso, il miracolo: Robin non mi rifiuta più, ascolta i miei comandi, collabora, mi capisce.
Che non fosse un miracolo l’ho capito più avanti. In quelle settimane, infatti, io e Robin ci siamo studiati, abbiamo imparato a fidarci l’uno dell’altra, a capire come comunicare, come anticipare i rispettivi movimenti.
Robin mi ha insegnato che non sempre, per ottenere quello che voglio, basta fare quello che mi piace, o che mi viene facile.
È più soddisfacente raggiungere un obiettivo cercando di migliorarmi, lavorando su qualcosa di imperfetto, piuttosto che raggiungerlo grazie a qualcosa di già pronto, che non ha bisogno che io migliori o che io lo aiuti a migliorare.
È una strada lenta, frustrante e faticosa a volte, e che richiede tanta disciplina, pazienza e ambizione.
Per me è la strada più potente di tutte.
Ex giocatore della Nazionale italiana di rugby, oggi Team Manager degli Azzurri e autore di una delle mete più significative della storia del rugby italiano, contro il Sudafrica.
Quando si presenta mi racconta di dividere la vita in pre- e post- rugby.
Il “pre” in realtà dura i suoi primi 9 anni: il classico bambino iperattivo, sempre alla ricerca di strani modi per sudare e fare fatica, che ha provato molti sport.
Com’è nata la tua passione per il rugby, tra tutti gli sport?
A 9 anni il mio amico del cuore aveva iniziato a giocare a rugby da poco. Un giorno eravamo insieme a casa sua e, a un certo punto, si rende conto di essersi dimenticato dell’allenamento di rugby. Ormai ero là con lui, e i genitori hanno portato anche me a provare l’allenamento. Mi sono innamorato subito di questo sport: quando mio padre è venuto a prendermi gli sono corso incontro, l’ho tirato per la maglietta e gli ho detto:
«Papà, ho deciso. Voglio giocare a rugby. Dimmi tutto quello che devo fare per arrivare in Nazionale». Avevo 9 anni e le idee chiarissime.
Spoiler, alla fine realizzi quel sogno. Cosa ti ha portato fino alla Nazionale?Sono partito da Avezzano, dove sono nato, concentrandomi totalmente su questo sport: volevo allenarmi tutti i giorni.
A 15 anni sono stato selezionato per giocare a Roma con la Capitolina, una squadra molto forte per la qualità di formazione delle giovanili. Ancora ringrazio i miei genitori per avermi lasciato andare. A 18 anni ho iniziato la mia carriera professionistica, prima con gli Aironi, poi con le Zebre e poi in Inghilterra a Newcastle con i Falcons.
E nel frattempo ho realizzato il mio sogno di giocare in Nazionale: a 21 anni ho fatto il mio esordio a Parigi, alla prima partita del Sei Nazioni: Italia-Francia, davanti a 82mila persone.
Sono stati anni di montagne russe, fin quando non mi sono ritirato nel 2019, appena prima del Covid.
Come mai hai preso questa decisione?
Nel mezzo della stagione mi sono detto: “Basta, sono ancora giovane per giocare ma anche giovane per decidere cosa fare per il resto della mia vita – che è tanto – e ci voglio arrivare bene, non voglio trascinarmi finché ce la faccio, trovandomi poi in ritardo per inserirmi nel mondo vero”.
Ho fatto un anno e mezzo lontano dal mondo della palla ovale, e ora mi occupo della gestione della squadra della Nazionale maggiore. In tutto questo, ho avuto la fortuna di crescere una splendida famiglia. Mia moglie e i miei tre bambini riempiono le mie giornate.
Hai vissuto tantissime vite! Concentrandoci su quella sportiva, hai mai pensato a qual è il tuo ricordo più bello sul rugby?
Vorrei dirti l’esordio, perché è arrivato molto presto e non ero pronto a vivere quelle emozioni. È stato un momento molto ricco. Ma ti dirò la partita col Sudafrica nel 2016, quando abbiamo vinto per la prima volta. Ci sono alcune Nazionali in questo sport che sono squadre fortissime, di un altro livello. Il Sudafrica è una di queste.
E per la prima volta a Firenze, culla del Rinascimento italiano, siamo riusciti a vincere una di queste squadre: un rinascimento del rugby italiano.
È la famosa partita in cui hai segnato la meta della vittoria.
Non ci crederai, ma per me quello è irrilevante: sono le settimane prima che contano davvero. Faccio un passo indietro. Due mesi prima della partita col Sudafrica mi rompo le costole e quindi non vengo convocato. Una volta ripreso dall’infortunio, gioco una partita in Scozia col Newcastle, segnando la meta della vittoria. Mentre sto andando in aeroporto per tornare in Italia, arriva una telefonata da parte del Team Manager della Nazionale, che mi chiede di prendere l’aereo da Edimburgo a Roma, senza passare da casa, per aggregarmi agli Azzurri. Dopo qualche giorno, e una sconfitta contro gli All Blacks, l’allenatore mi chiede: “Giamba, come la vedi la partita contro il Sudafrica?”. E io ho risposto che se avessimo mantenuto la stessa intensità di gioco, avremmo potuto vincere. La sua birra rimane a mezz’aria, mi guarda incredulo e la conversazione finisce lì.
E poi?
La mattina dopo a colazione si avvicina per dirmi che sabato avrei giocato da titolare. Ero partito da non convocato, poi sono stato convocato ma in panchina, e alla fine avrei giocato da titolare. Avevo una gran voglia di rivalsa, e ho giocato una delle migliori partite della mia carriera.
Aver fatto la meta della vittoria per me è veramente irrilevante. È il percorso che c’è stato prima che mi ha fatto assaporare di più quella giornata. Quello è il ricordo più bello: Firenze, novembre 2016.
Sono d’accordo con te: tante volte è il percorso che ti porta a raggiungere un obiettivo che rende un ricordo più bello. Sono curiosa anche di sapere qual è la cosa più difficile che hai fatto nella tua carriera sportiva; non deve essere facile aver detto “basta” alla tua carriera.
È vero. E in realtà mi sentivo pronto, avevo fatto tante esperienze oltre lo sport, avevo una laurea, un master. Ma il pomeriggio in cui è stata diffusa la comunicazione ufficiale sono rimasto chiuso in bagno per cinque ore: ho pianto tutte le mie lacrime, mi tremavano le gambe, non riuscivo a muovermi. Solo in quel momento stavo realizzando cosa era appena finito. Quello che mi ha colpito di più è stato l’affetto da parte di tutti: avevo già un rapporto splendido con i tifosi, ma ho capito davvero quello che avevo fatto quando ho ricevuto attestati di stima da tutto il mondo.
Finché ci sei dentro è tutto un frullatore, pensi che quella sia la normalità: vai, schizzi, riparti. È quando fai un passo fuori che vedi quanto andavi veloce prima, e ti rendi conto di tutto quello che hai vissuto in 12 anni, che per me sono volati. Non li sostituisci con nient’altro.
La tua famiglia che ruolo ha avuto in questa decisione?
Tu conta che a 21 anni, quando ho esordito con la Nazionale, ero padre già da un anno. Non mi sono mai dedicato solo allo sport, il rugby era sempre accompagnato dalla paternità e dalla famiglia.
Non voglio nemmeno pensare a cosa sarebbe cambiato se avessi fatto diversamente, perché condividere tutto con la mia famiglia è stata una benedizione enorme. Mio figlio ha visto tutto, ed è stato bellissimo. È anche vero che uno dei motivi che mi ha convinto a smettere di giocare è stato proprio il dover stare per molto tempo lontano da casa e dai miei figli. Tutto quello che volevo fare l’ho fatto, mi sono divertito tantissimo, ed era tempo di fare altro.
Avere qualcuno con cui condividere le esperienze è una delle cose che rendono speciali i sogni, e le persone a cui tieni spesso ti danno la spinta per superare momenti difficili. A volte però bisogna superarli con le proprie forze. Tu come hai superato i momenti di fatica per andare avanti e raggiungere i tuoi obiettivi?
Sarebbe l’occasione perfetta per darti una risposta motivazionale. In realtà, la risposta motivazionale secondo me è fuffa. Ogni volta che ho contato solo sulla voglia di fare qualcosa è andata male.
Ti spiego perché: il sogno di fare qualcosa ce l’hanno tutti. Immagina 23 rugbisti pochi minuti prima del calcio di inizio, che si danno la carica negli spogliatoi, dall’altra parte del muro c’è l’altra squadra che si sta caricando allo stesso modo. Non può vincere chi lo vuole di più. Ho capito che non è tanto la motivazione ma il processo, la preparazione.
Vincere grazie alla motivazione è come sperare di vincere il biglietto della lotteria. In generale l’essere umano spera nell’evento ed evita il processo. In realtà invece è tutto lì. È un processo lento e continuo, è fatto di abitudini. So che suona noioso, ma è quella la strada. Non tutti ce la fanno perché non tutti vogliono seguire quella strada noiosa.
Immagino che in questo processo la disciplina sia molto importante. Cosa vuol dire per te “avere disciplina”?
La disciplina è stata la mia salvezza ed è l’unica arma che abbiamo contro la mediocrità e contro i fallimenti.
Ho una foto di me stanco morto, inginocchiato dopo un allenamento, e indossavo una maglietta con scritto “Discipline equals freedom”. Se pensi alla disciplina immagini tutte le privazioni che dovrai affrontare, invece è vero che la disciplina è libertà: se sei disciplinato, vai verso il tuo obiettivo passo dopo passo, e ti liberi dalla paura di fallire.
Io ho sempre fatto tantissimi sport e sono cresciuta con degli allenatori che mi hanno insegnato cosa vuol dire allenarsi e cosa è la disciplina. E come dici tu, mi sono sempre sentita libera di provare tutto quello che volevo, perché avevo capito che c’è sempre un modo per imparare qualcosa.
A questo proposito, ho visto anche che parli molto di crescita personale. Secondo te che obiettivi bisogna darsi, nello sport o nella vita, e quando possiamo considerare di averli raggiunti?
Quando siamo consapevoli di non averli raggiunti, e probabilmente di non raggiungerli mai. È quello che ti spinge a fare qualcosa in più ogni giorno, non sperando solo nella fortuna. È una questione di approccio, di adattamento e di voglia di andare sempre oltre, senza aver paura di sbagliare.
Miglioramento personale vuol dire provare ad avere sempre più informazioni, a conoscere sempre di più, a conoscersi sempre di più.
Ho visto che segui il progetto Clutch Academy, che utilizza lo sport come strumento formativo per le aziende. Secondo te quali sono i valori che lo sport può insegnare ai professionisti?
Lo sport è spesso usato come metafora, ma chi l’ha praticato sa che è molto di più. L’idea romantica dello sport ispira le persone, ma gli sportivi sanno che la stessa fatica che fa un campione la fa anche chi non arriva. Il percorso è brutto, lungo, duro e neanche tanto bello da raccontare. Con Clutch ci siamo detti che dobbiamo raccontare anche questo lato dello sport, e abbiamo selezionato degli sportivi con capacità di creare ponti tra le varie realtà, che ci danno una mano a spiegare la loro esperienza.
Qual è la cosa più importante che ti ha insegnato lo sport?
Sicuramente la capacità di adattamento alle persone. Lo sport ti fa condividere spogliatoi, esperienze, emozioni con tante persone diverse, ti insegna tanto.
Prima dicevi che tutti hanno un sogno, e che la risposta motivazionale non basta. E hai detto anche che la crescita personale vuol dire sapere di non arrivare mai alla fine della crescita. Io credo molto in questa cosa: chiunque ha dei sogni, che cambiano crescendo, e probabilmente non ci si sentirà mai realmente “arrivati”. Volevo sapere cosa ne pensi anche tu.
Nel tuo percorso pensi di essere riuscito a realizzare il tuo sogno?
Ho sempre avuto un grande senso di agonismo e non penso che l’essere competitivo abbia dei lati negativi: finché riesci a tenere salde le priorità – che per me sono la mia famiglia, i miei genitori che stanno ad Avezzano, la mia famiglia allargata – quindi finché so di non intaccare le cose veramente importanti, non ho paura di impegnarmi per raggiungere un sogno.
Me ne puoi dire uno?
Quando andavamo insieme in montagna in Abruzzo, quasi arrivati in cima, mio padre mi diceva: “Dai, fammi una corsa fino alla fine”. Io ci provavo ma mi scoppiavano le gambe. E lui rispondeva, “Non preoccuparti, sei arrivato fino a quel cespuglio, ora riposa 2 minuti e poi prova a superarlo”. Quindi mi rimettevo a correre, un pezzo alla volta. Nel giro di qualche giorno sono riuscito a correre tutta quell’ultima salita. E adesso mi rendo conto che quel modo di affrontare le cose è proprio quello che mi serve oggi, per raggiungere i miei obiettivi.
Oggi il mio sogno è di avere nuovi sogni, spesso.
Mi piace cambiare spesso, farmi trovare pronto, fare anche quando sono confuso su dove sto andando. Spero che la mia vita sia sempre scandita da queste cose, così non mi annoio.
Potete continuare a seguire la storia di Giovanbattista su Instagram.
Grazie per aver letto fin qui.
Per me è stato molto utile parlare con Giovanbattista di quanto la disciplina sia importante per raggiungere i propri obiettivi. Spero sia stato interessante anche per te, e se hai voglia di parlarne, scrivimi!